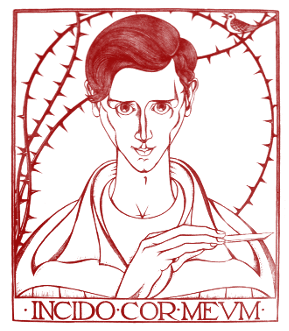Il cielo è un brodo rosso solcato da filamenti bianchi. Colori sporchi vibrano nella neve sporca. Il rumore è un’iniezione nel cervello. Rannicchiato in una buca cieca, il soldato Cáceres non ha paura. Pensa che lo spettacolo valga la pena, anche se il prezzo dev’essere la paura. All’improvviso è come se gli togliessero la siringa, lasciandogli un vuoto doloroso. Un rumore si stacca dal rumore. Una manciata di terra e di neve colpisce il soldato Cáceres. Un silenzio gommoso gli tappa le orecchie.
Quando riapre gli occhi, il cielo è bianco, abbagliante, liscio. E il silenzio continua, un silenzio punteggiato da rumori sgocciolanti, friabili: passi, voci, strumenti metallici. Il suolo è morbido. Il suolo è un letto, un letto in una stanza d’ospedale. Un cannello di plastica gli arriva al braccio. Le mani gli fanno male.
Un giovane medico si avvicina guardandolo di sottecchi.
«Stai calmo» gli dice. «Guarirai.»
«Le mie mani» dice il soldato Cáceres. «Come stanno le mie mani?»
Il medico storce la bocca.
«Non ci sono» dice, sorridendo a un vaso di fiori appassiti. «Non ci sono più.»
Non era l’unica cosa che aveva perso.
I giorni all’ospedale erano lunghi, una galleria di ombre che si perdeva in un buco nero. Il buco era lontano. Immobilizzato sulla sedia a rotelle, lui non poteva raggiungerlo. La galleria era opaca come un vetro di bottiglia, e dietro il vetro c’erano delle ombre. A volte le ombre gli si avvicinavano e acquisivano un profilo confuso. I loro tratti si deformavano quando si appoggiavano al vetro, e le voci risuonavano distanti, voci avvolte nel cotone.
Oggi c’è un piatto speciale per te, gli diceva un’ombra. Pollo. Vuoi che ti metta da parte una coscia in più? E l’ombra gli strizzava l’occhio, gli accarezzava i capelli attraverso il vetro opaco. Il soldato Cáceres guardava il panno che lo copriva dalla cintura in giù. Una coscia in più, ripeteva scioccamente. Oppure l’ombra gli si avvicinava per offrirgli una sigaretta. Il soldato Cáceres alzava i monconi delle braccia, e l’ombra, pazientemente, gli metteva la sigaretta in bocca, gliela accendeva, la divideva con lui. Poco alla volta il vetro si incrinò. Alicia, gli disse un giorno un’ombra, mi chiamo Alicia. E la voce sembrava adesso di questo mondo, un mondo dove gli orologi battevano le ore e il tempo passava. Alicia gli raccontava storie di altri feriti di guerra, e di come erano guariti. O di come non erano guariti. Lui non parlava mai.
Quando cominciò a stare meglio (questo almeno gli dissero, che stava meglio), passava la giornata davanti al finestrone. Si trovava a un piano elevato, e guardando dal finestrone vedeva il movimento all’esterno. Il movimento erano camion militari che caricavano bare, elicotteri che scaricavano cadaveri e feriti nel piazzale, jeep che entravano e uscivano, gruppi di donne senza uniforme che portavano pacchetti e fiori, ma il movimento non era movimento perché gli mancava il rumore. Senza il vetro del finestrone vi sarebbe stato rumore, ma sempre e ancora vi sarebbero stati altri vetri per isolarlo dal vero rumore, l’iniezione nel cervello. Al centro del piazzale ondeggiava la bandiera. Non pendeva mai dall’asta. C’era sempre vento e ondeggiava sempre. Il soldato Cáceres guardava la bandiera e cercava nella propria memoria; cercava qualcosa che lo strappasse al sopore, qualcosa che rompesse tutti i vetri. Un giorno ricordò le parole di una canzone patriottica e la cosa gli fece piacere. Gli fece talmente piacere che quando Alicia attraversò il corridoio il soldato Cáceres si mise a ridere.
«Vedo che stai meglio» disse Alicia avvicinandosi.
«Quando morirò» disse il soldato Cáceres, diventando serio di colpo. Non si poteva dire se fosse una domanda o cosa.