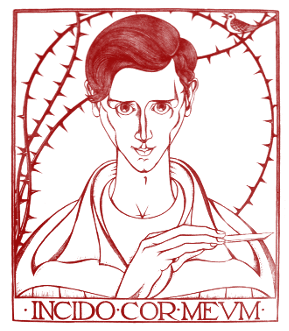Lo scrittore sollevò lo sguardo, si alzò lentamente dalla poltrona su cui stava dormicchiando e mi fissò.
«E poi?»
«Non so.»
«Lei però mi ha detto che il fulcro della storia è Hollywood. Una Hollywood messicana.»
«Esatto. L’ipotesi è che i nordamericani non abbiano vinto la guerra del 1847, e che la California, l’Arizona e il Nuovo Messico siano rimasti messicani. La seconda ipotesi è che gli emigranti europei che diedero vita all’industria cinematografica, all’inizio del secolo, lo avrebbero fatto in territorio messicano, su una collina dei dintorni di Los Angeles chiamata Santobosque.»
«E perché mi racconta questa storia?»
«Ho sentito dire in giro che le interessano le ucronie.»
«Mi interessa la sua ipotesi. Io non sarei nato, non mi troverei qui e questa conversazione non si starebbe svolgendo…»
«Non necessariamente, anche se le cose sarebbero abbastanza differenti.»
Si tolse gli occhiali e si portò la mano alla testa. Doveva smaltire l’effetto di una dozzina di barbiturici. Pensava lentamente. Stava perdendo i capelli per colpa della marijuana. Si accese un sigaro, un Regio di Nayarit.
«E io come mi chiamerei, se le cose fossero andate così?»
«Non saprei, immagino Felipe K. Cazzo.»
«Non mi piace.»
«In effetti non è molto onorevole. Suona malissimo» dissi, ammettendo la sfortuna.
«Quindi, lei verrebbe a raccontarmi questa storia e nel giro di pochi istanti, o di qualche ora, o di qualche giorno, dovrebbe arrivarmi una telefonata con la proposta di girare un film basato su uno dei miei romanzi. Per la precisione, una versione cinematografica del Cacciatore di androidi.»
«Immagino di sì.»
«Ma Los Angeles continuerebbe a essere Los Angeles?»
«Ci sono più rivendite di tacos che nella versione della California nordamericana, più mariachi, ma sì. E poi la sua storia è ambientata nel futuro. Ma che importa?»
«Senta…» mi domandò inquieto, «e Griffith e la Nascita di una nazione?»
«Il film ha avuto un grande successo. L’ha girato Eulalio Bedoya.»
«Quarto potere l’ha fatto Orson Welles?»
«Sì, e appena finite le riprese ha sposato Dolores del Rio e ha preso la nazionalità messicana. Vive a Veracruz.»
«Gli Stati Uniti senza Hollywood non esistono».
«Più o meno. Lincoln ha perso la guerra di secessione, Chaplin è sbarcato ad Antigua, ma ha girato lo stesso Il grande dittatore. Il Texas ha conservato l’indipendenza, l’Indio Fernandez ha girato L’angelo azzurro con Marlene Dietrich. Pola Negri e Buster Keaton vivono ancora a Tijuana. A Pearl Harbour non è successo niente, in compenso i giapponesi hanno bombardato Cabo San Lucas… Si presume che lei sia cittadino di un paese senz’anima.»
«Immagino che ce lo meritiamo» disse Philip Dick dirigendosi verso il frigorifero per prendere una birra Sol, poi tornò strascicando le ciabatte e pensò che Felipe K. Cazzo non era un nome così brutto, in fin dei conti.
Quando rientrò nella sua stanza l’inviato non c’era più, io me n’ero andato. Non sembrò dare troppa importanza alla mia scomparsa.
Si sedette alla macchina e cominciò a scrivere, furiosamente. Se quelli del cinema gli avrebbero comprato un romanzo che non aveva ancora scritto, era meglio scriverlo. Come aveva detto che si intitolava? I fottuti robot sognano pecore meccaniche? Era meglio scriverlo, e sarebbe stato meglio che la telefonata arrivasse dopo, per concedergli la settimana extra di cui aveva bisogno.
Le luci del boulevard Santobosque entravano con forza, assumendo il colore arancione di una tenda e diffondendo nella stanza i riflessi della cornice d’argento di uno specchio di Taxco.
Il ticchettio dei tasti era musica. Musica di Vangelis, perché le cose non erano cambiate poi tanto.
(Pubblicato su Pulp n. 52, 2004.)