Mentre era impegnato a tracciare la sua «mappa della palude» della letteratura italiana contemporanea che tante polemiche ha suscitato, il critico teatrale e scrittore Franco Cordelli ha trovato anche il tempo per fare una scorribanda nella nuova narrativa messicana e ha dato conto delle sue letture in un pezzo intitolato: «Sotto le stelle del Messico a inventare trame. E quelle di Sada sanno di trasgressione» (La Lettura del «Corriere della sera» del 18/5/14).
 Dopo un paragrafo in cui percorre a volo d’uccello i nomi degli autori messicani più noti, Paz, Rulfo, Fuentes, passando per Taibo II e Mastretta, Cordelli arriva a Pitol e Pacheco, e poi ai più giovani – Villoro, Bellatin, Volpi, Herrera, Villalobos, Nettel e Monge –, di cui fornisce pedantemente le date di nascita e niente più. Per Cordelli si tratta di una «quantità impressionante», ma in effetti se ne è lasciati sfuggire un bel po’, altrimenti avrebbe senz’altro scritto esplicitamente «una quantità eccessiva». (Senza andare troppo lontano, io ho tradotto tre romanzi e due raccolte di racconti di Enrique Serna, due romanzi di Cristina Rivera Garza e un noir di Joaquín Guerrero Casasola. Inoltre sono stati tradotti Jorge Ibargüengoitia, Laura Esquivel, Carmen Boullosa, Margo Glantz, Élmer Mendoza, Valeria Luiselli, Ignacio Padilla, Rafael Bernal, e recentemente di Josefina Vicens e Juan García Ponce, e l’elenco non è affatto esaustivo.)
Dopo un paragrafo in cui percorre a volo d’uccello i nomi degli autori messicani più noti, Paz, Rulfo, Fuentes, passando per Taibo II e Mastretta, Cordelli arriva a Pitol e Pacheco, e poi ai più giovani – Villoro, Bellatin, Volpi, Herrera, Villalobos, Nettel e Monge –, di cui fornisce pedantemente le date di nascita e niente più. Per Cordelli si tratta di una «quantità impressionante», ma in effetti se ne è lasciati sfuggire un bel po’, altrimenti avrebbe senz’altro scritto esplicitamente «una quantità eccessiva». (Senza andare troppo lontano, io ho tradotto tre romanzi e due raccolte di racconti di Enrique Serna, due romanzi di Cristina Rivera Garza e un noir di Joaquín Guerrero Casasola. Inoltre sono stati tradotti Jorge Ibargüengoitia, Laura Esquivel, Carmen Boullosa, Margo Glantz, Élmer Mendoza, Valeria Luiselli, Ignacio Padilla, Rafael Bernal, e recentemente di Josefina Vicens e Juan García Ponce, e l’elenco non è affatto esaustivo.)
Pacheco (1939-2014) e Pitol (1933) finiscono poi inspiegabilmente arruolati tra i «nuovi scrittori messicani» (insieme a Yuri Herrera, Mario Bellatin e Juan Villoro) che Cordelli ha letto: «Ne ho letti cinque: cinque libri brevi. Mi hanno deluso tutti».
José Emilio Pacheco viene spacciato in tre righe che fanno dubitare fortemente che Cordelli si sia preso davvero la briga di leggerlo: «La battaglia del deserto di Pacheco è il racconto di un amore giovanile, che rimane in sospeso prima che il protagonista se ne vada a New York».
Intanto, il titolo corretto del romanzo è Le battaglie nel deserto, e Pacheco non è stato «prima poeta e poi narratore», bensì il contrario. Ma poi, si può definire «amore giovanile» quello di un bambino che frequenta le elementari per la madre di un suo compagno di scuola? Il racconto peraltro non rimane affatto «in sospeso»: Carlos bigia le lezioni per dichiararsi alla bella Mariana, ma il suo amico gli fa la spia, cosicché scoppia uno scandalo e i genitori lo portano da un sacerdote e da uno psicologo e lo ritirano dalla scuola. (Gustosissima la scena della confessione, quando il prete gli domanda se si è toccato e se c’è stato derrame.) Dopo di che Carlos viene a sapere che la donna oggetto del suo desiderio è morta suicida. E non è che «il protagonista se ne va a New York»: trattandosi di un bambino, sono i genitori a portarcelo.
Soprattutto, siamo proprio sicuri che Le battaglie nel deserto sia solo «il racconto di un amore»? Non vi ha letto Cordelli la nascita del Messico moderno e la scomparsa del paese tradizionale, l’ingresso nel mondo ipocrita degli adulti, la ricreazione di una città e di una memoria collettiva?
Diciamo le cose come stanno, e come può verificare qualsiasi lettore: Le battaglie nel deserto è un piccolo capolavoro – 67 pagine nella mia edizione messicana del 2010, la 17a –, ed è considerato tale non solo nel continente americano ma ovunque sia stato tradotto (in Russia e in Giappone, oltre che in tutti i paesi europei).
Un altro dei libri recensiti da Cordelli che Cordelli probabilmente non ha letto è Salone di bellezza di Mario Bellatin. Lo si evince scorrendo le poche righe che gli dedica: «Salone di bellezza di Bellatin racconta anch’esso una trasformazione, quella di un salone di bellezza in una specie di acquario-rifugio per alienati e malati in genere (ma confesso di non averlo capito affatto)». Alienati e malati in genere? A chiunque legga il libro dovrebbe risultare chiaro che si tratta di ammalati di Aids. Anche se Bellatin non fa mai il nome della malattia, gli elementi che offre sono inequivocabili. Cosa fa pensare invece a Cordelli che si tratti di «alienati»? E cosa sarebbe un «malato in genere», laddove si specifica che si tratta di malati terminali? Cordelli confessa di «non averlo capito affatto», ma farebbe meglio a confessare di non averlo letto. Come ha scritto con acutezza Francesca Lazzarato, per anni «nessuno si è azzardato a pubblicare un autore considerato troppo sperimentale per il nostro pubblico, nonché lontano dalle tipologie di scrittura latinoamericana tutt’ora radicate nell’immaginario dei lettori e anche in quello di molti critici».
Di La vita coniugale di Sergio Pitol e La ballata del re di denari di Yuri Herrera ci vengono offerti due tweet assolutamente neutri da Cordelli, che preferisce accanirsi invece contro Chiamate da Amsterdam di Juan Villoro («poco più che una variazione su temi esauriti perfino nel cinema»), prima di passare a spiegarci perché tutti e cinque questi libri lo hanno deluso: «Questi romanzi brevi sono deludenti per lo stesso motivo, perché sono privi di stile, ovvero sembrano scritti (per quanto si può giudicare da una traduzione) in uno stile per così dire internazionale: anonimo, anodino. C’è poi un’altra questione cruciale. Sto parlando di romanzi brevi. Ma la narratività contemporanea è tutt’altro che breve. Al contrario, è lunga, fluente, avvolgente, fatta di racconti che non finiscono mai».
Privi di stile? Uno «stile per così dire internazionale»? Ohibò. Che Sergio Pitol e José Emilio Pacheco siano privi di stile è un’affermazione talmente gratuita e spropositata che non vale la pena di commentarla.
Prendiamo invece un giovane come Yuri Herrera, autore di una trilogia (La ballata del re di denari, Segnali che precederanno la fine del mondo e La trasmigrazione dei corpi, pubblicati i primi due da La Nuova Frontiera e il terzo da Feltrinelli, tutti tradotti da Pino Cacucci) che ha suscitato il massimo interesse della critica proprio per l’assoluta originalità del linguaggio, «che parte dall’oralità messicana contemporanea per estendersi verso i territori dell’invenzione verbale, dell’accumulo e della circonlocuzione», come ha scritto Patricio Pron. E il suo approccio al narcotraffico è stato caldamente elogiato da un critico come Rafael Lemus, feroce nei confronti di tanta letteratura del Nord del Messico che ha affrontato questa tematica in modi stereotipati. Il suo linguaggio è così poco «anonimo e anodino» che il bravo Cacucci ha dovuto inserire una nota (in La trasmigrazione dei corpi) per spiegare la traduzione di Alfaqueque, reso con Mediatore: «L’autore usa un termine derivato dall’arabo e che in Spagna significava “redentore di prigionieri” […]».
Ma la vera questione cruciale, per Cordelli, quello che proprio non gli va giù, è la brevità di questi romanzi, quando, a suo dire, «la narratività contemporanea è tutt’altro che breve». Be’, dovrà farsene una ragione: nell’America di lingua spagnola, e in Messico in particolare, succede esattamente il contrario, e non da ieri. Già agli inizi del Novecento Mariano Azuela, che ci ha lasciato il più bel romanzo della Rivoluzione messicana, Los de abajo, ha scritto notevoli romanzi brevi, e così pure Amado Nervo e Xavier Villaurrutia. Negli anni Quaranta è stata la volta di Francisco Tario e di Efrén Hernández, negli anni Cinquanta di Juan José Arreola, Juan García Ponce e Ricardo Garibay.
Come ha scritto Juan José Saer nel prologo all’edizione dei romanzi brevi di Juan Carlos Onetti: «Verso il 1960, fra i narratori giovani che si lanciavano nel lavoro letterario, la forma che incarnava la massima aspirazione estetica, il modello di qualsiasi perfezione narrativa, non era né il romanzo né il racconto, ma il romanzo breve. […] il fascino che esercitava il romanzo breve decadde solo quando, a metà degli anni Sessanta, il genere “grande romanzo d’America”, patetica sovrapposizione di stereotipi latinoamericani destinata a conquistare il mercato anglosassone, piegandosi nel contenuto e nel formato alle sue norme commerciali, sloggiò dalle librerie i discreti e ammirati volumi di un centinaio di pagine circa che perpetuavano tanti capolavori». E di tutta l’opera di Carlos Fuentes non sono pochi a preferire di gran lunga la sua nouvelle fantastica Aura (appena 90 smilze paginette).
Fortunatamente, è successo che generazioni di scrittori successivi al boom degli anni Sessanta hanno poi rifiutato l’idea del narratore onnisciente, del romanzo totalizzante, dell’epopea, della saga familiare, del polpettone storico, per abbracciare l’estetica del frammento, della testimonianza individuale, del punto di vista decentrato e obliquo.
Con la loro mania della brevità, gli scrittori ispanoamericani hanno addirittura inventato un genere, leminificciones, racconti brevissimi, a volte di poche righe, il cui celeberrimo capostipite riconosciuto è «Quando si svegliò, il dinosauro era ancora lì», del guatemalteco Augusto Monterroso.
Se poi abbandoniamo per un momento il Messico, c’è il caso eclatante dell’argentino César Aira, che dopo aver esordito alla fine degli anni Settanta con alcuni romanzi «lunghi», sulle 200 pagine, ha imboccato con decisione la strada della nouvelle, con romanzi che spesso non raggiungono le 100, al ritmo di tre-quattro l’anno; e siccome ha la vocazione del provocatore, ha pubblicato in uno stesso volume un romanzo e un racconto… dove il racconto è più lungo del romanzo.
Cordelli però, bontà sua, ha voluto dare un’altra chance alla letteratura messicana, e così si è «deciso a scegliere tra due romanzi veri e propri, due romanzi lunghi»: Non sarà la terra di Jorge Volpi eQuasi mai di Daniel Sada. Del primo nulla ci dice perché ha preferito il secondo, ma si sbarazza subito della bandella – l’accostamento a Joyce e Lezama Lima gli sembra fuori luogo, come pure il riferimento al barocco – per rivelarci che: «La cosa vera, evidente, è l’apparizione, in questo romanzo, d’uno stile personale». Finalmente! vien voglia di urlare. Quello che segue però fa cascare le braccia: «Ovviamente non del tutto personale: i primi accenni di punteggiatura (i puntini di sospensione) ci parlano di Céline; poco più avanti si capisce che il faro di Sada è però Gombrowicz, in modo inequivocabile. Per due ragioni: la presenza ossessiva dei due punti, quella degli esclamativi, la povertà di verbi: insomma uno stile nominale al massimo grado». Ora, senza imbarcarsi in una problematica definizione di che cosa sia lo stile (personalmente mi accontento di quella suggerita dal poeta cileno Enrique Lihn, secondo cui «lo stile è il vomito», tanto per chiarire che è qualcosa che viene da dentro), ridurlo a una questione di punteggiatura mi sembra una boutade di cattivo gusto.
Quanto alla tematica: «Sada ha un chiodo fisso, quello della trasgressione, e per lui, o almeno in Quasi mai, la trasgressione è tutta chiusa nel mondo della sessualità».
Ancora una volta è necessario contraddire Cordelli, e per farlo basterà confrontare i suoi giudizi con quelli di Christopher Domínguez Michael, fra i più noti critici letterari ispanoamericani, in una recensione al romanzo pubblicata nel gennaio 2009 nella rivista Letras libres: «Casi nunca è uno studio della vita di provincia e un romanzo erotico. […] Non abbondano da noi i romanzi erotici, e quelli scritti dalla generazione precedente (come quelli di Juan García Ponce) si situano sotto l’imperio della trasgressione, un’ubbidienza estranea a Sada. Sada non è sadiano: i mille e uno ritorni al coito che si verificano in Casi nunca appartengono al regno della libertà spensierata, godereccia, degli altri libertini, quelli che hanno trovato nella naturalezza del sesso, senza lasciarsi intristire dalla ruota della tortura o dal ricatto romantico, l’unica attività che giustificava la nostra breve permanenza nel mondo». E diversamente da quanto scrive Cordelli («Demetrio abbandona al suo destino la puttana Mireya per guardare alla santità del sesso attraverso il matrimonio con Renata»), così argomenta Christopher Domínguez Michael, per il quale Sada è «padrone di una prosa che lo rende il più inconfondibile dei narratori nella nostra lingua»: «Il lieto fine del romanzo sta nel trionfo della natura, diciamo così, sulla società: “il sesso-motore, il sesso-angoscia” governerà l’alcova della nuova coppia come aveva illuminato la camera del bordello».
E così, nemmeno Sada alla fine si salva dalla furia di Cordelli, perché la sua ironia, «la sua ansia d’assoluto che va a poco a poco riducendosi nell’idea del “quasi mai separati”, si trasforma, fino a dilagare, in spiritosaggine».
Ma lo sconcerto nel leggere questo pezzo di Cordelli arriva al culmine con la frase conclusiva: «Scopriamo che la bruschezza mitopoietica della partenza (una specie di scoperta del nuovo nel vecchio) stava diventando risoluzione del vecchio nel nuovo per una specie di abuso faustiano dell’elisir da Sada scovato, fino a deturparne il sembiante, nell’altrui letteratura».
Be’, se qualche anima buona volesse illuminarmi sul significato sibillino di questa frase, gliene sarei grato.
In conclusione, si apre una serie di domande che forse meritano una malinconica riflessione collettiva: è lecito scrivere un pezzo che vorrebbe essere un’analisi della recente letteratura messicana, infarcito di giudizi approssimativi e dissennati, senza conoscere la lingua né gli autori di cui si parla? Senza essere in grado di contestualizzarli? Che senso ha un’operazione del genere? Un tempo, negli anni Sessanta e Settanta, sul «Corriere della Sera» e altri quotidiani italiani, a scrivere dei «nuovi autori» ispanoamericani di allora – Neruda, Borges, Rulfo, García Márquez, Vargas Llosa, Cortázar – erano emeriti ispanisti come Dario Puccini e Federico Tentori Montalto, critici come Goffredo Fofi, scrittori come Guido Piovene, poeti come Mario Luzi e Gianni Toti. Oggi basta essere una «firma» per poter scrivere impunemente qualsiasi cordelleria? È da decenni che si scrive e si dibatte dell’inesorabile e vertiginoso declino della critica letteraria, ma qualcuno poteva immaginare una deriva simile?
(Pubblicato sul blog di Sur il 25 giugno 2014.)
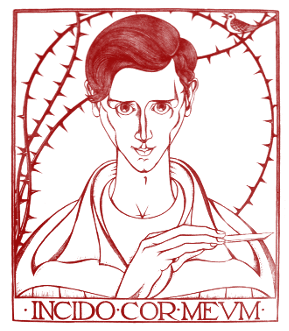
 Dopo un paragrafo in cui percorre a volo d’uccello i nomi degli autori messicani più noti, Paz, Rulfo, Fuentes, passando per Taibo II e Mastretta, Cordelli arriva a Pitol e Pacheco, e poi ai più giovani – Villoro, Bellatin, Volpi, Herrera, Villalobos, Nettel e Monge –, di cui fornisce pedantemente le date di nascita e niente più. Per Cordelli si tratta di una «quantità impressionante», ma in effetti se ne è lasciati sfuggire un bel po’, altrimenti avrebbe senz’altro scritto esplicitamente «una quantità eccessiva». (Senza andare troppo lontano, io ho tradotto tre romanzi e due raccolte di racconti di Enrique Serna, due romanzi di Cristina Rivera Garza e un noir di Joaquín Guerrero Casasola. Inoltre sono stati tradotti Jorge Ibargüengoitia, Laura Esquivel, Carmen Boullosa, Margo Glantz, Élmer Mendoza, Valeria Luiselli, Ignacio Padilla, Rafael Bernal, e recentemente di Josefina Vicens e Juan García Ponce, e l’elenco non è affatto esaustivo.)
Dopo un paragrafo in cui percorre a volo d’uccello i nomi degli autori messicani più noti, Paz, Rulfo, Fuentes, passando per Taibo II e Mastretta, Cordelli arriva a Pitol e Pacheco, e poi ai più giovani – Villoro, Bellatin, Volpi, Herrera, Villalobos, Nettel e Monge –, di cui fornisce pedantemente le date di nascita e niente più. Per Cordelli si tratta di una «quantità impressionante», ma in effetti se ne è lasciati sfuggire un bel po’, altrimenti avrebbe senz’altro scritto esplicitamente «una quantità eccessiva». (Senza andare troppo lontano, io ho tradotto tre romanzi e due raccolte di racconti di Enrique Serna, due romanzi di Cristina Rivera Garza e un noir di Joaquín Guerrero Casasola. Inoltre sono stati tradotti Jorge Ibargüengoitia, Laura Esquivel, Carmen Boullosa, Margo Glantz, Élmer Mendoza, Valeria Luiselli, Ignacio Padilla, Rafael Bernal, e recentemente di Josefina Vicens e Juan García Ponce, e l’elenco non è affatto esaustivo.)