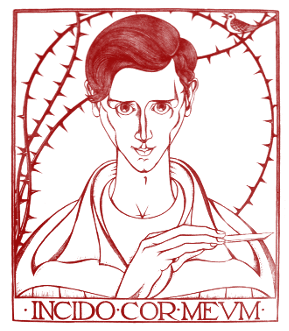(seconda parte)
Mi svegliai quarantotto ore dopo in un sotterraneo maleodorante. Immagino che mi avessero dato una dose di sonnifero capace di stordire un cammello. Non vidi mai in faccia i sequestratori. Temendo che potessi identificarli, quando mi portavano da mangiare indossavano maschere di Paperino. Disteso in un giaciglio pidocchioso, sentivo il gocciolio della pioggia, gli squilli di un telefono, il lontano ronzio dei tram. A tormentarmi, più della scomodità, era non sapere quale sarebbe stato il mio destino. Avrebbero chiesto un riscatto alle autorità di New Blackwood? Mi avrebbero strappato la pelle per venderla al mercato nero?
Recuperai la serenità quando uno dei rapitori ebbe la bontà di dirmi che mi trovavo ad Amburgo. Il mio furto era stato un lavoretto commissionato dal magnate tedesco Heinrich Kranz, meglio conosciuto come il Re delle Nevi per la sua implicazione nel traffico internazionale di cocaina. Kranz aveva ordinato di non portarmi via dal sotterraneo fino al giorno del compleanno della moglie: voleva farle una sorpresa. Venni condotto con gli occhi bendati in un castello nella Selva Nera – la casa in campagna di Kranz – dove si teneva la festa. In un salone enorme, illuminato con gli effetti pirotecnici di una discoteca, era riunito il fior fiore dei corrotti del jet set europeo. Appena mi ripresi dalla vertigine iniziale, contemplai inorridito alcune sagome che in seguito mi sarebbero divenute familiari.