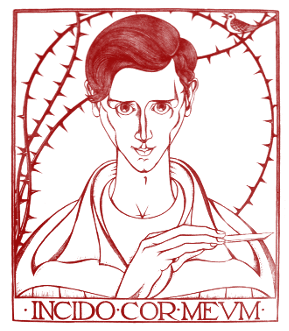Un giorno di ottobre di tre anni fa ci lasciava, novantenne e lucido, Ramiro Pinilla. È sufficiente dire Ramiro: era così che lo conoscevamo. Era della classe di mio padre, il 1923. E non coincidevano solo nell’età. Entrambi erano legati al mondo del lavoro, che Ramiro, prima nella marina mercantile, poi in una fabbrica di gas e in una casa editrice, combinò come poté con la scrittura. Erano appassionati di calcio, uno tifava per i biancorossi dell’Atlético Madrid e l’altro per i biancoazzurri dell’Espanyol di Barcellona. È possibile che in quei colori iniziasse e terminasse la loro unica religione. Credevano inoltre in quella sinistra internazionalista, proletaria, che propugnava la fratellanza tra i popoli e i diritti dei lavoratori, e che a quel tempo non sapeva niente di bandiere regionali né subordinava i suoi principi ai sentimenti identitari.
Ramiro e mio padre avevano vissuto la guerra civile da adolescenti, e senza avervi partecipato erano stati sconfitti. Forse in uno di quei giorni di esplosioni e di fumo i due ragazzi si erano incrociati in una strada di Bilbao. Mio padre era stato imbarcato su una nave da carico gremita di bambini rifugiati diretta in Francia. Se l’avessero portato in Russia, io non sarei nato. Ramiro si trascinò per tutta la vita il ricordo tenebroso della repressione. Decenni dopo, si ricordava ancora di quei falangisti del primo dopoguerra che rastrellavano le case di Gexto e dei dintorni in cerca di carne da mettere al muro. Ne parlò in alcuni passi dei suoi romanzi; e sono il tema centrale di La higuera, uno dei suoi testi che apprezzo maggiormente.
Ramiro Pinilla impiegava quel tipo di umorismo sotterraneo il cui scopo originario non è provocare le risate, ma conficcare nell’interlocutore, come senza volerlo, un pungiglione di sottile ironia. Era un uomo di significati, più che di preziosismi formali. Ha lasciato detto che scriveva perché parlava poco. Una sorta di compensazione, dunque, che a mio parere non esaurisce le profonde motivazioni della sua scrittura, alla quale non difettano né la testimonianza dell’epoca né la coscienza sociale. Soprattutto nel romanzo, ma anche nei racconti, trovò la forma che meglio si adattava alle sue enormi doti di narratore.
Provava una immediata avversione per la ciarlataneria. Diffidava dei termini ricercati, dei discorsi prolissi e dell’esibizione di luoghi comuni, per non parlare della magniloquenza. Si era formato in un gran numero di giornate lavorative come un uomo a cui la vita non aveva regalato niente senza il tributo dello sforzo. Ramiro non viene dall’università, ma dalla perseveranza dell’uomo laborioso che esercita il talento con senso pratico in un mondo che gli è avverso, nel quale, tuttavia, poté trovare qualche rifugio: la casa che chiamò Walden, il frutteto, la pratica della letteratura.
Propugnava la chiarezza concettuale e la prosa invisibile. Il lettore doveva formarsi la storia nella propria testa senza avvertire la fastidiosa mediazione del linguaggio. Ramiro aveva questo piccolo dogma che un giorno, con la sfacciataggine di un figlio, gli avevo contestato durante una conversazione. E lui si era soffermato a riflettere e a me era parso di capire il suo atteggiamento: «Non so rispondere, ma domani o dopodomani vedremo, altrimenti, vieni al mio laboratorio di scrittura e ti spiego». Io gli avevo detto semplicemente – con la tipica ironia della provincia basca di Guipuzcoa, simile a quella della vicina Biscaglia ma diversa – che era grazie al barocco se esisteva lo stile piano; che se non fosse per il favore che noi brutti facciamo ai belli, la loro bellezza non esisterebbe, e infine, che se tutti scrivessimo allo stesso modo, basterebbe che lo facessero in tre o quattro. Lui aveva assunto l’espressione di chi è disposto a pensarci, ma non mi ha mai dato ragione.
Seguendo il filo di queste rimembranze, mi ricordo una scena di cui fui testimone anni fa, in occasione della Fiera del Libro di Madrid. Dopo aver svolto il compito delle firme, ci ritiravamo in gruppo dal Retiro (perdonate il gioco di parole), e un tale che non è il caso di menzionare mostrava una certa loquacità. Ramiro se ne stava in silenzio. D’un tratto interruppe il flusso verbale del suo giovane collega letterato per dirgli: «Senti, tu parli molto, no?». Ramiro, già avanti con gli anni, continuava ad avere i suoi giorni combattivi. Quello fu uno di quei giorni. Poco dopo, mentre eravamo seduti al tavolo di un ristorante, tirò fuori senza motivo il tema delle corride di tori. Le detestava. Alcuni appassionati di corride presenti cercarono di vendergli la festa avvolta nel cellophane delle argomentazioni. L’arte, il rito secolare e tutte queste cose. Ho visto onde più grandi infrangersi su rocce meno dure.
Nei romanzi di Ramiro Pinilla abbondano i testardi. Si tratta di personaggi caratterizzati da una tenacia epica, spesso spinta alle estreme conseguenze con una passione ossessiva, con una sorta di fanatismo di origine tellurica che conferisce loro dimensioni tipiche delle figure della tragedia classica. Tragedia che non di rado sorge da un impegno eccessivo, addirittura sovrumano, e che riguarda l’intero clan familiare, come nel caso di Sabas Jáuregui, il patriarca di Las ciegas hormigas, o come gli amanti o gli umiliati di Verde valles, colinas roja, che custodiscono nel petto, fino alla fine dei loro giorni, le braci di una passione amorosa o la furia sorda di un rancore indistruttibile. In Ramiro c’era qualcosa di questa perseveranza elementare, indomabile, adamantina. Una volta gli domandai quanto tempo avesse impiegato per scrivere – nella solitudine di casa sua, in cattivi rapporti con il mondo editoriale dell’epoca – Verdes valles, colinas rojas, la sua monumentale epopea di baschi nei dintorni di Gexto, la capitale della sua letteratura. Venti, rispose con la sua solita laconicità, e come per dire che se gliene fossero occorsi altri venti se li sarebbe presi. O trenta. O quelli necessari. Aveva l’abitudine di scrivere a mano. Accanto alla sua scrivania, sul pavimento, continuava a crescere la pila di fogli manoscritti. Sensatamente, l’editore consigliò al romanziere di dividere in tre parti, che rimanevano voluminose, Verdes valles, colinas rojas. «Questo tuo libro è destinato a durare» gli dissi una sera mentre eravamo insieme al bancone di un bar-ristorante. Non rispose, ma io intuisco che, alla maniera di mio padre, tenne a mente l’affermazione per soppesarla in solitudine. E quando finì la cena collettiva, mi prese in disparte e mi rivolse qualche parola in tono confidenziale: «Dove l’ho lasciato, devi continuare tu». L’affresco con le storie di gente dei Paesi Baschi da lui dipinto arriva fino agli anni Sessanta del XX secolo e, di conseguenza, fino agli albori della violenza terrorista. In certo qual modo, il mio romanzo Años lentos nacque quella sera, non tanto dalla volontà di sostituirmi al maestro insuperabile, ma piuttosto di adempiere l’incarico a in quanto figlio letterario. Conservo un altro ricordo commovente di Ramiro. In due occasioni lo sentii raccomandare a noi che lo accompagnavamo, con la saggezza dell’uomo anziano, di dire ai nostri genitori una cosa molto semplice: che li amavamo, e di farlo prima che fosse troppo tardi.
(Pubblicato su Robinson di Repubblica.)