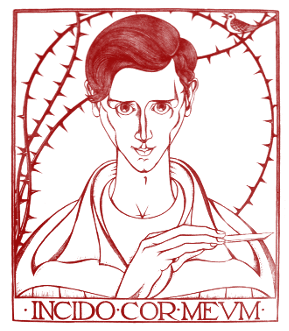La serva e il lottatore, di Horacio Castellanos Moya (trad. di Enrica Budetta, Rizzoli, 252 pagg., 18 euro) appartiene a un gruppo di quattro romanzi – l’autore non ama la definizione di “saga” –, pubblicati fra il 2004 e il 2011, che ruotano intorno all’epopea della famiglia Aragón e inquadrano alcuni momenti cruciali della storia di El Salvador, come la sollevazione popolare contro il regime del dittatore Maximiliano Hernández Martínez del 1944 o la breve e cruenta guerra con l’Honduras del 1969. La trama si sviluppa nel giro di pochi giorni del 1980, alla vigilia dell’assassinio dell’arcivescovo Óscar Romero e dello scoppio della guerra civile che insanguinerà il paese fino al 1992, con oltre 80.000 vittime, opponendo i guerriglieri del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (Fmnl) a una serie di governi guidati da militari con l’attivo sostegno di Ronald Reagan e degli Stati Uniti. Divennero tristemente famosi gli squadroni della morte, che fecero scomparire migliaia di militanti di sinistra, e proprio un ex membro di questi gruppi paramilitari, Robocop, è il protagonista dell’unico romanzo di Castellanos Moya tradotto finora in Italia, L’uomo arma (La Nuova Frontiera, 2006): dopo la smobilitazione, diventa un delinquente comune. E non si è trattato di “casi isolati”: basti pensare che la Mara Salvatrucha – una delle bande più numerose, ramificate e crudeli della delinquenza organizzata che infesta il Centroamerica, alcuni Stati occidentali degli Usa e il Canada – è nata a Los Angeles proprio da espatriati salvadoregni.
Protagonisti di La serva e il lottatore non sono più i membri della famiglia Aragón, salvo un nipote del vecchio Pericles, ma i due personaggi “minori” (non “marginali” bensì “popolari”, secondo una precisazione dell’autore) evocati nel titolo: una vecchia domestica e un poliziotto con un passato da wrestler. I due si erano conosciuti tempo prima, quando lavoravano per lo stesso padrone, lui come guardia del corpo. Allora El Vikingo le aveva fatto la corte senza successo, ma si reincontrano in circostanze drammatiche, quando María Elena si rivolge a lui per avere notizie sulla scomparsa del nipote dei loro ex datori di lavoro e poi assiste all’attentato di un commando di rivoluzionari che vorrebbero liquidare il poliziotto. La distanza che separa i due personaggi non potrebbe essere più grande. Lui, protagonista della prima parte del romanzo, è cinico, spietato e rancoroso, vive nel ricordo nostalgico del suo passato di lottatore, ma è soltanto uno squallido sicario che “lavora” nel Palazzo Nero, la camera di tortura della polizia, e ormai l’unica lotta che conduce è quella con un’ulcera devastante che gli provoca continui conati di vomito e gli dà un alito pestilenziale. Lei è tutta emozioni e sentimenti positivi verso il prossimo, animata da un autentico spirito comunitario, ingenua come può esserlo una donna di umili origini ed estremamente timorosa; ammira monsignor Romero, il “difensore dei poveri”, e nasconde come un segreto il nome dell’uomo che l’ha messa incinta. La seconda parte del romanzo, in cui la sua figura è centrale, smorza un po’ i colori tipici del noir – senza che venga meno la cappa di terrore – per aprire una parentesi di tono quasi melodrammatico, con alcuni siparietti fra la serva e la cugina che ricordano i dialoghi di una telenovela. Il contrasto non potrebbe essere più brutale. Poi gli eventi si succedono a una velocità vertiginosa, entra in azione un gruppo di giovani rivoluzionari che prepara attentati, e uno di loro è proprio il nipote di María Elena, che lo riconosce dall’abbigliamento. Sono sequenze decisamente cinematografiche. Di più non occorre dire, se non per precisare che i colpi di scena non finiscono lì.
I personaggi si muovono in spazi asfittici e repellenti: la trattoria della Gorda Rita, che deve proteggere la figlia quattordicenne dai clienti, poliziotti libidinosi e assolutamente privi di scrupoli, la sala delle torture del Palazzo Nero, dove si consumano anche bestiali stupri, gli ospedali in cui vengono ricoverati El Vikingo e María Elena, colpita da un collega dell’ex lottatore. Lo stile di Castellanos Moya è secco, essenziale, spietato anche nei confronti del lettore, costretto a respirare l’atmosfera velenosa del sospetto, dell’angoscia, dell’orrore. Come scrisse Roberto Bolaño – la frase è riportata anche sulla copertina del libro –, «Ogni pagina risuona di paura, e così chi legge. L’America Latina è questa».
Horacio Castellanos Moya è nato a Tegucigalpa, in Honduras, nel 1957. Da bambino si è trasferito nel Salvador, paese natale del padre, dove ha vissuto fino al 1979. Poi se n’è andato per sottrarsi alle violenze che avvelenavano la vita sociale, destinate a degenerare di lì a poco nella guerra civile, e ha iniziato un pellegrinaggio che lo ha condotto a Toronto, in Costa Rica e in Messico. Oltre alle collaborazioni giornalistiche, ha insegnato fra l’altro all’università di Pittsburg e di Tokyo e negli ultimi anni nello Iowa. Nel 1988 pubblica il suo primo romanzo, scritto in Messico, La diaspora, in cui affronta il tema della disillusione fra i gruppi che avevano sognato la rivoluzione (per restare in Centroamerica, abbiamo Los compañeros di Marco Antonio Flores, del 1976 e Sopa de caracol di Arturo Arias, del 2002, entrambi guatemaltechi).
Nel 1996 esce Baile con serpientes, un esperimento nella traiettoria dell’autore: il realismo sucio tipico del romanzo urbano si mescola con l’elemento fantastico – i serpenti del titolo prendono vita dentro un’auto, parlano, fanno persino sesso con il protagonista e scatenano un’apocalisse in città – e ne risulta un singolare poliziesco in cui scorrono liberamente lo humour nero e il sarcasmo. Il ritorno di Castellanos Moya a El Salvador si interrompe nel 1999, due anni dopo la pubblicazione del romanzo che gli ha procurato una certa fama: El Asco: Thomas Bernhard en San Salvador. (“Asco” significa nausea, ribrezzo, disgusto.) La critica demolitrice dell’autore, che assume la forma di un lungo monologo estremamente polemico (come quello che Bernhard ha dedicato all’Austria) si rivolge contro la società sorta alla fine della guerra civile. Riceverà minacce di morte che lo costringeranno di nuovo all’esilio. Con La diabla en el espejo Castellanos Moya si esibisce in una prova di bravura: si tratta del monologo di una donna – rivolto a una interlocutrice immaginaria – che indaga sull’omicidio di un’amica; il che permette all’autore di esplorare il registro stilistico dell’oralità, di penetrare nella psicologia femminile e, en passant, di aggiungere un altro tassello al suo puzzle che raffigura El Salvador. Infatti, è soltanto con l’ultimo romanzo pubblicato nel 2018, Moronga (termine che indica un salsicciotto, ma anche il pene), che i suoi personaggi, sempre centroamericani, si spostano negli Stati Uniti, in una cittadina universitaria immaginaria che somiglia molto a quella frequentata da Castellanos Moya come professore.
(Pubblicato su alfabeta2)