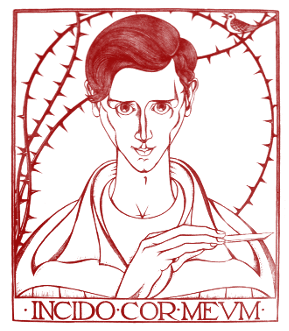(A proposito di Tradurre un continente)
Nel 2013 Sellerio ha pubblicato un volume di grande interesse per tutti i traduttori, gli ispanisti e in generale per gli appassionati di letteratura latinoamericana, Tradurre un continente. La narrativa ispanoamericana nelle traduzioni italiane, a cura di Francesco Fava.
Riporto qui, in due parti (la seconda parte sarà disponibile mercoledì), la recensione che pubblicai a suo tempo sul blog delle edizioni Sur.
 Che cosa “ci è arrivato” di scrittori come García Márquez, Borges, Cortázar, Arguedas, Rulfo e altri appartenenti al cosiddetto boom della letteratura latinoamericana degli anni Sessanta e Settanta attraverso le traduzioni italiane? E cosa si è perso per strada? È utile e opportuno, a distanza di quasi cinquant’anni dalla pubblicazione delle prime traduzioni, fornire ai lettori italiani versioni più attendibili? Nell’introduzione del curatore si affronta di petto il problema: «… nella traduzione italiana di Cien años de soledad, la “ciudad de los espejos (o los espejismos)” si trasforma in “una città degli specchi (o degli specchietti)” [laddove espejismos significa invece “miraggi”; ndr]. Una banale svista, come ne capitano a ogni traduttore e in ogni traduzione. Ma anche molto di più, sul piano degli effetti per chi legge. Mentre gli evocativi miraggi di García Márquez spariscono dall’orizzonte ottico del lettore italiano ancor prima di essere affrontati, si attiva imprevista una risonanza del tutto diversa: gli specchietti e le altre cianfrusaglie che i primi conquistadores rifilavano agli indigeni americani in cambio di pietre preziose e delle altre “meraviglie” del nuovo continente… E che nello scambio lessicale di una traduzione rischi di perpetuarsi quell’originario commercio ingannevole è un’eventualità – come si vede – sempre in agguato.»
Che cosa “ci è arrivato” di scrittori come García Márquez, Borges, Cortázar, Arguedas, Rulfo e altri appartenenti al cosiddetto boom della letteratura latinoamericana degli anni Sessanta e Settanta attraverso le traduzioni italiane? E cosa si è perso per strada? È utile e opportuno, a distanza di quasi cinquant’anni dalla pubblicazione delle prime traduzioni, fornire ai lettori italiani versioni più attendibili? Nell’introduzione del curatore si affronta di petto il problema: «… nella traduzione italiana di Cien años de soledad, la “ciudad de los espejos (o los espejismos)” si trasforma in “una città degli specchi (o degli specchietti)” [laddove espejismos significa invece “miraggi”; ndr]. Una banale svista, come ne capitano a ogni traduttore e in ogni traduzione. Ma anche molto di più, sul piano degli effetti per chi legge. Mentre gli evocativi miraggi di García Márquez spariscono dall’orizzonte ottico del lettore italiano ancor prima di essere affrontati, si attiva imprevista una risonanza del tutto diversa: gli specchietti e le altre cianfrusaglie che i primi conquistadores rifilavano agli indigeni americani in cambio di pietre preziose e delle altre “meraviglie” del nuovo continente… E che nello scambio lessicale di una traduzione rischi di perpetuarsi quell’originario commercio ingannevole è un’eventualità – come si vede – sempre in agguato.»
L’annotazione di Francesco Fava – nel saggio “La frontiera mobile dell’esotismo” – compendia sinteticamente i due versanti su cui si sviluppano le riflessioni di tutti gli autori dei vari saggi raccolti nel volume – ispanisti di chiara fama –, pur nella diversità degli approcci: la discussione critica delle traduzioni italiane della narrativa ispanoamericana e la ricezione nel nostro paese dell’immaginario veicolato da questa letteratura.
Proprio su Cent’anni di solitudine si sofferma Lorenzo Blini, che muove dalla constatazione della scarsità di contributi critici sugli aspetti linguistici del testo e riprende le analisi svolte da Francesco Varanini nel Viaggio letterario in America Latina: «Varanini lo descrive come “una macchina retorica codificata, facile da montare e smontare”, e cerca di svelarne i segreti, elencandone le regole: la ridondanza, la centralità dell’aggettivazione, l’abuso di effetti come manifestazione di autorevolezza, l’esotismo come giustificazione dell’assurdo e del grossolano, l’intertestualità autoreferenziale, l’esclusione di ogni valore emotivo». Per ricordare anche analoghe osservazioni espresse nel 1979 da Pasolini: «Un altro luogo comune (pare) è quello di considerare Cent’anni di solitudine (recentemente ristampato) di Gabriel García Márquez un capolavoro. Ciò mi sembra semplicemente ridicolo. Si tratta del romanzo di uno scenografo o di un costumista, scritto con grande vitalità e spreco di tradizionale manierismo barocco latinoamericano […] I personaggi sono tutti dei meccanismi inventati talvolta con splendida bravura da uno sceneggiatore: hanno tutti i “tic” demagogici destinati al successo spettacolare».
Il saggio di Blini offre una brillante ed esaustiva illustrazione di questi approcci critici attraverso un’analisi linguistica del romanzo di García Márquez che muove dalla ricorrenza di particolari termini e aggettivi. Veniamo così a sapere che gli aggettivi più usati sono “primero”, “único” e “último” («Primero e último sono modificatori che collocano il modificato alle estremità di una gamma, mentre único riassume in sé la gamma intera, è l’estremo assoluto»). E già nelle prime pagine di Cien años de soledad ci troviamo di fronte un profluvio di aggettivi estremi, assoluti, saturi, che non vengono però applicati a sostantivi semanticamente solidali: «… tarde remota, truculenta demostración, desaforada imaginación, enorme calabazo, asombrosa claridad, pantanos desmesurados, ríos tormentosos…». Blini, al quale non difetta certo un sano piglio militante, commenta allibito: «Sembrano aggettivi estratti dalla sceneggiatura di un film di Indiana Jones, e invece si tratta del capolavoro di un premio Nobel».
Passando ai problemi posti dalla traduzione, Blini non è meno esplicito né severo: la traduzione di Cien años de soledad non presenta particolari difficoltà – linearità sintattica, semplicità del lessico, uniformità stilistica, scrittura tradizionalista –, e in questo senso l’unica disponibile, quella di Enrico Cicogna, che di García Márquez fu anche amico (pubblicata da Feltrinelli solo quattro mesi dopo l’uscita dell’originale per Seix Barral), non può certo considerarsi soddisfacente, per ragioni che vengono ampiamente argomentate: indebito innalzamento del registro stilistico per amplificare l’effetto di “meraviglia” e accentuare l’esotismo del testo, numero eccessivo di prestiti e calchi, sovrabbondanza di indebiti neologismi, ecc. «Sembra dunque che Cicogna si sia complicato le cose senza motivo, e le abbia complicate un po’ anche ai lettori italiani.»
Viene ricordato anche l’intervento di Valerio Riva, all’epoca “traghettatore” in Italia di diversi scrittori latinoamericani: « … io stesso avevo affidato a Cicogna la traduzione di Cent’anni di solitudine, ma mi ero sbagliato: il risultato era stato a dir poco deprimente. Lo dovemmo ritradurre interamente, mot à mot, io e Marcello Ravoni […] Fu un lavoro massacrante, di quelli che si ricordano con sgomento». Accantonando la diatriba, anche perché i protagonisti sono tutti defunti, Blini chiosa: «Lo sgomento è comunque la sensazione che condividiamo constatando che il pubblico italiano deve continuare ad acquistare e a leggere una traduzione con questa storia e con le caratteristiche evidenziate in precedenza. Chiunque ne sia stato l’autore, l’edizione italiana del 1968 ha fatto il suo tempo: se è comprensibile che allora, in assenza di un’adeguata riflessione teorica, il livello di consapevolezza dei traduttori fosse limitato, e che le politiche editoriali fossero faccende che si sbrigavano in ristretti circoli elitari, non è accettabile che oggi continuino a essere proposti nelle librerie testi condizionati da pregiudizi linguistici e ingenuità traduttive, continuando a spacciarli per operazioni colte e raffinate».
Si può essere più chiari di così? Ebbene sì, infatti nelle righe conclusive Blini infligge l’ultima stilettata alle suddette politiche editoriali tornando sul mezzo secolo che ci separa dalla traduzione firmata da Cicogna: « … che peraltro dovrebbe aver consentito di ammortizzare l’impegno economico necessario per il compenso del traduttore. Saremo condannati anche noi a cent’anni di solitudine, senza una traduzione all’altezza di un libro così importante, famoso e venduto?».
Quello di Blini del resto non è l’unico intervento che discute criticamente le strategie editoriali nei confronti delle “vecchie” traduzioni di testi ispanoamericani. (Sorge il dubbio che il destinatario finale del volume, più che i traduttori o aspiranti tali, o comunque gli studiosi e i lettori più attenti e curiosi della letteratura ispanoamericana, siano proprio gli editori.)
Francesco Fava, per esempio, muovendo da una minuziosa e affascinante disamina del brevissimo racconto di Borges “La casa di Asterión” e della traduzione di Francesco Tentori Montalto – messa a confronto con la revisione operata dal curatore Tommaso Scarano insieme ad Antonio Melis e Fabio Rodríguez per la nuova edizione Adelphi del 1998 –, segnala puntualmente difetti che sono anche vezzi inveterati di talune traduzioni (giustamente stigmatizzati anche da altri interventi): le aggiunte o le sottrazioni, le soppressioni, l’indebito passaggio dalle percezioni sensoriali ai concetti astratti, la scarsa considerazione dell’intertestualità e del gioco con le fonti… Fava inoltre, a partire dalla constatazione che il Tentori Montalto ha tradotto “fatigar” in sei modi diversi, ma una sola volta usando “affaticare”, mentre traducendo una poesia di Borges dove compare lo stesso termine è ricorso a “stancare”, ne desume che: «… attraverso questo esempio mi pare si possa cogliere in azione un radicato pregiudizio in base al quale si ritiene che la poesia (e quindi la sua traduzione) debba necessariamente essere “poetica” […], mentre alla prosa si dovrebbe richiedere innanzitutto di “scorrere”, alludendo con questo verbo all’obiettivo di un’elegante leggibilità non ostruita da eccessive bizzarrie che ne interrompano il “naturale” fluire. In accordo con quest’idea, nella traduzione poetica si concederà maggior rilievo all’elemento stilistico-formale, laddove invece in quella dei testi in prosa entreranno sovente in gioco meccanismi di razionalizzazione, semplificazione, etc. Un approccio quantomeno discutibile in linea generale; più che mai impraticabile per accostarsi alla scrittura narrativa di Borges.»
Per concludere con un giudizio che è anche un saggio consiglio di cui tutti i traduttori dovrebbero far tesoro: «Paradossalmente, la traduzione di Tentori Montalto rende più complicata la fruizione di “La casa de Asterión” proprio perché tenta di facilitarla. La tua facilità, non semplifica, si potrebbe dire citando Paolo Conte. Un ritornello che ogni traduttore farebbe bene a canticchiare di tanto in tanto, durante il proprio lavoro, per evitare di cedere alla tentazione di semplificazioni o neutralizzazioni immancabilmente infruttuose. Scorciatoie che si rivelano piste false, finendo per sortire un effetto opposto a quello auspicato: non producono maggior chiarezza, ma soltanto minore coerenza interna e dunque opacità. […]»
Segue un denso saggio di Gabriele Bizzarri, “Fertili ‘disincontri’: appunti per una poetica della traduzione cortazariana” dedicato alla raccolta Deshoras, del 1982, che non ebbe mai da noi una pubblicazione autonoma e figura soltanto nell’edizione Einaudi-Gallimard del 1994. Dopo un breve excursus per inquadrare la pubblicazione e la ricezione delle opere di Cortázar in Italia, Bizzarri individua i motivi della scarsa fortuna editoriale di questo «gioiello incastonato, considerato incapace di brillare di luce propria» precisamente nelle difficoltà traduttive. Che si complicano per il fatto che Cortázar, oltre ad aver svolto per tanto tempo la professione di traduttore, ha sviluppato nella sua opera una vera e propria “poetica della traduzione”, problematizzando il gesto di “tradurre” le cose nei loro “nomi”: «La traduzione diviene, dunque, per Cortázar, il campo in cui si sonda l’impossibilità della corrispondenza, ci si confronta con l’evidenza di una realtà senza nome, come in un altro celebre racconto [“Lettera a una signorina a Parigi”; ndr] che, di nuovo, è costellato di riferimenti letterali e metaforici all’attività traduttiva – come se la frequentazione professionale dello scrittore argentino con il mestiere di chi è costretto alla disperante ricerca della parola appropriata, gli avesse insegnato un’intera cosmovisione».
(Un giorno – sempre che non sia già stato fatto, o che sia possibile farlo malgrado la proliferazione incessante delle sue “novelitas” – qualcuno dovrà condurre uno studio sulla tematica della traduzione nell’opera di César Aira, un altro scrittore che ha svolto questo mestiere per decenni e che ha affrontato spesso il tema della traduzione nei suoi libri. A partire da due lavori fondamentali: Las vueltas de César Aira di Sandra Contreras e alcuni saggi raccolti in César Aira, une révolution, numero speciale della rivista francese “Tigre”.)
Dopo un’accurata discussione dei notevoli problemi posti dalla traduzione italiana, Bizzari formula un giudizio sostanzialmente positivo: «Cecilia Rizzotti ci restituisce Cortázar in modo piuttosto prudente, ma anche osservando un’oculatezza e una precisione senz’altro raccomandabili». Ed è forse l’unico caso “di assoluzione” fra quelli presi in esame, il che indubbiamente fa riflettere e suona giustamente di monito per chi (come me) svolge questo mestiere.
Macondo, il paese delle allodole / 2
Il saggio di Norbert von Prellwitz dedicato alle traduzioni di tre romanzi di Vargas Llosa, il più breve del volume, è anche estremamente specifico, incentrato com’è sul problema della resa traduttiva degli aspetti toponomastici (con un utile confronto fra le traduzioni italiane e quelle in altre lingue europee). Si tratta peraltro di problemi che si presentano pressoché a tutti i traduttori, o sui quali intervengono spesso le redazioni delle case editrici: devo tradurre “calle”, “avenida”, “esquina”, “malecón”? (Enrico Cicogna, al contrario di Angelo Morino e Glauco Felici), ha preferito “via”, “viale”, ecc.; come rendere i soprannomi? Vanno tradotti oppure no? E come usare correttamente i corsivi per non disorientare il lettore?
Von Prellwitz conclude con un’osservazione ampiamente condivisibile: «Dico questo nella piena consapevolezza di avere a mia volta commesso sfondoni nelle mie traduzioni: il fatto è che da una parte l’analisi degli errori è forse più facile da esporre rispetto a quella degli esiti più riusciti, ma sono pure convinto che si impara non solo dalla imitazione dei buoni modelli, bensì anche dalle incongruenze e dagli errori propri ed altrui. Attraverso la discussione sui criteri – soggetti anch’essi a variare nel tempo – un’attività come quella del tradurre, che ha come orizzonte fatale l’imperfezione, può mirare a essere meno imperfetta».