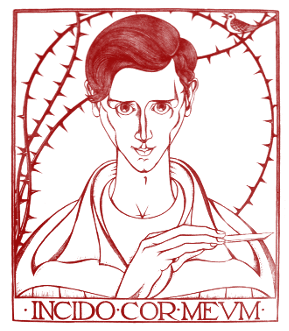Se n’è andato anche Carlos Fuentes. Nel maggio del 2002 ho avuto occasione di intervistarlo per la rivista Pulp, nel giardino dell’albergo milanese in cui soggiornava in occasione della pubblicazione in Italia del suo romanzo Le relazioni lontane. Saranno state le cinque di pomeriggio e lui era reduce da una lectio magistralis all’Università cattolica. Per di più, ero l’ultimo di una serie di intervistatori e me lo immaginavo stanco e scarsamente motivato. Invece mi sono trovato di fronte una persona rilassata e molto bendisposta. Si è illuminato in volto quando ho detto all’interprete che non c’era più bisogno di lei e non ha fatto obiezioni alla presenza del microfono. Poi, sorseggiando il suo whisky con ghiaccio, ha cominciato a rispondere di buon grado alle mie domande. A seguire il testo dell’intervista preceduto da una breve introduzione.
Forse il Nobel non glielo daranno mai, hanno sempre la scusa (contemplata nello statuto) che quei soldi non gli servirebbero, ma di tutti gli altri premi internazionali ha fatto incetta. I suoi numerosi romanzi, tra i più letti e incensati nel mondo ispanico, sono stati tradotti in tutto il mondo (in italiano si possono leggere La morte di Artemio Cruz, Aura, Le relazioni lontane, Gli anni con Laura Díaz, Il gringo vecchio, Orchidee al chiaro di luna), così come molti saggi (Geografia del romanzo e Tutti i soli del Messico), e gli studi dedicati alla sua opera costituiscono già una bibliografia impressionante. Carlos Fuentes, classe 1928, messicano, è uno dei nomi cruciali del cosiddetto “boom” della letteratura latinoamericana, oltre che uno straordinario “ambasciatore” culturale del suo paese e del subcontinente americano. Quanti volumi ci vorrebbero per raccogliere le interviste che ha rilasciato nella sua vita? Le probabilità che ho di non annoiarlo rivolgendogli domande inaudite devono essere bassissime… Oltre tutto, è reduce da un’applauditissima conferenza all’Università Cattolica di Milano e da una sfilza di colloqui e interviste. Decido di rompere il ghiaccio portandogli i saluti dello scrittore argentino César Aira, e vedo il suo viso illuminarsi – malgrado quell’impertinente, in un romanzo, abbia tentato niente meno che di clonarlo, convinto che “con 100 Carlos Fuentes si potrebbe prendere il potere mondiale” –, e scopro che non è affatto difficile come immaginavo entrare in sintonia con un monumento letterario, così parto con le domande.
È uscito in Spagna il suo ultimo libro, En esto creo, annunciato come un’autobiografia in forma di dizionario. A quanto pare lei vuole continuare a sorprendere critici e lettori con le sue sperimentazioni formali…
No… è stato in seguito a un invito dell’editore francese Grasset, per una collana inaugurata da Mauriac quarant’anni fa, e quando abbiamo preso accordi per il libro ho deciso di farlo in forma di dizionario, di scrivere un Credo; non è un’autobiografia, è piuttosto un Credo. E mi rifaccio a una tradizione antica come quella dei dizionari filosofici del XVIII secolo, o a esperimenti molto più recenti come quelli di Georges Steiner, Czeslaw Milosz o dello stesso Milan Kundera, che ha scritto un saggio di questo genere. Quindi non è affatto una novità, a volte in questo modo si ordinano molto bene le idee, tutto qui.
Il suo primo romanzo di successo, L’ombelico del mondo, affronta fra l’altro il tema della città, della realtà urbana. Lo scrittore Sergio Pitol ha affermato: “È un romanzo che torna d’attualità ogni volta che si verifica un avvenimento politico e sociale importante in Messico”. Sarà per questo che si continua a ripubblicarlo e a tradurlo? Malgrado le accuse di oscenità [ride] quando uscì nel 1958, per non parlare degli insulti dei difensori a oltranza della Rivoluzione messicana incorruttibile ed eterna…
Be’, si spera sempre che un romanzo sia altrettanto nuovo del suo prossimo lettore… Prendiamo per esempio un classico come il Don Chisciotte di Cervantes. L’importanza del Chisciotte non si riduce al fatto di essere stato scritto sotto il regno di Filippo III di Spagna, nelle circostanze particolari della Spagna di allora, no? Invece si rivolge sempre all’immaginazione di un nuovo lettore, del prossimo lettore. Io spero che in qualche misura L’ombelico del mondo sia un romanzo abbastanza emblematico di Città del Messico, come lo è stato Manhattan transfert di Dos Passos per New York, o Alexander Berlinerplatz di Döblin, o come molti altri esempi di romanzi ambientati in una città. I romanzi urbani sono quasi un genere, ci sono molti romanzi che ruotano intorno alla vita di una città, è un modo per affrontare un romanzo. Del resto sono sicuro che la Parigi di Balzac o la Londra di Dickens non sono più, e probabilmente non sono mai state, come le hanno descritte loro, eppure la descrizione che ci hanno offerto della Parigi e della Londra del XIX secolo è quella che si è fissata nella nostra immaginazione. Magari è successa la stessa cosa con L’ombelico del mondo, anche se è un romanzo che ha alle spalle già mezzo secolo di vita.
Secondo un critico, infatti, si tratta di una versione avanguardista de La comédie humaine di Balzac.
[Ride] Sì, è possibile, perché ho letto molto Balzac e provo grande gratitudine nei suoi confronti, e sicuramente ne sono stato influenzato.
In un’intervista lei ha detto che Ixca Cienfuegos, uno dei personaggi principali del romanzo, è il suo Raskolnikov.
[Ride] Non ricordavo di averlo detto. Sicuramente ci può essere anche un’influenza di Dostoevskij. Sì, è un personaggio che ha qualcosa di malefico, è piuttosto ambiguo e intrattiene rapporti con forze molto oscure, è anche un “diavoletto”, le diable boiteux, che solleva il coperchio, i tetti delle case, per vedere cosa succede dentro. O, come ha scritto Luis Vélez de Guevara nel Diablo cojuelo, per vedere cosa succede nel pasticcio di carne avariata della città di Madrid. Ixca Cienfuegos vuol vedere cosa succede nel pasticcio di carne avariata di Città del Messico.
Molti, se non tutti, i personaggi dei suoi romanzi, lottano strenuamente per avere la loro identità, così come le società latinoamericane. E questa lotta si sviluppa anche sul piano del linguaggio. Per esempio, nella Morte di Artemio Cruz ci sono tutti quei cambi dalla prima alla seconda e alla terza persona. Immagino che anche per lei si sia posto un problema d’identità legato alla lingua, avendo imparato l’inglese da bambino e vissuto in tante parti del mondo.
Io mi sono reso conto ben presto che la letteratura in lingua inglese non aveva bisogno di un altro scrittore. È una letteratura molto ricca, e poi, quando è in crisi, arriva sempre qualche irlandese per darle un calcio nel culo e svegliarla. È successo con Swift, Shaw, Joyce. Non c’è granché da dire in inglese che non sia già stato detto, se non dal di dentro della lingua inglese. Invece sentivo che nella lingua spagnola c’era un vuoto straordinario. Il Chisciotte fonda il romanzo moderno, ma dopo ilChisciotte non ci sono grandi romanzi spagnoli fino alla seconda metà del XIX secolo, con Clarín e Pérez Galdós, e poi Valle-Inclán e quel che è seguito. Perché questo vuoto così straordinario? Come mai non ci sono romanzieri che abbiano qualcosa da dire per riempirlo? Di lì i romanzi “totalizzanti”, come sono stati chiamati, di Vargas Llosa, García Márquez… i miei anche, che cercavano di dire tutto il “non detto” durante quel passato silenzioso. Di lì nasce anche una certa ambizione, un progetto narrativo che si è sviluppato più in spagnolo che in inglese, naturalmente. A me è bastato trovarmi a Buenos Aires e leggere Borges, quando avevo quindici anni, per rendermi conto delle enormi possibilità della lingua spagnola e dell’immaginazione in spagnolo. D’altra parte, io credo che in buona misura noi ci siamo guadagnati la nostra identità. La battaglia per l’identità è stata vinta. In Messico definitivamente. Ormai non costituisce più un problema, sappiamo bene chi siamo. Il problema oggi è la diversità. Partire dall’identità per scoprire la diversità, rispettare la diversità, quella politica, etica, religiosa, sessuale, tutte le diversità possibili che finora non abbiamo saputo conquistare allo scopo di costruire una democrazia vivente in Messico e in America latina: oggi è questa la sfida, è questo il problema.
La morte di Artemio Cruz si inscrive nella cosiddetta “narrativa della Rivoluzione messicana”. In un saggio per il 30° anniversario della sua pubblicazione lei ha scritto: “La rivoluzione di Artemio Cruz è soltanto una delle molte rivoluzioni che è stata la Rivoluzione messicana. Non è quella di Zapata o di Pancho Villa; la sua è la rivoluzione di Carranza e Obregón: centralizzatrice, modernizzatrice, statalista e capitalista”. Cosa resta oggi di queste rivoluzioni messicane?
Resta la costruzione di un paese che era inconcepibile nel 1910. Nel 1910 avevamo un paese di 13 milioni di abitanti, oggi sono 100, gli analfabeti erano il 90%, oggi sono il 25%. Avevamo un paese privo di vie di comunicazione, mentre oggi esiste una buona rete di comunicazioni. La sua struttura era fondamentalmente feudale agraria, mentre oggi è fondamentalmente industrializzato e dedito al commercio estero. Era un paese completamente orientato all’imitazione dell’Europa e della cultura europea, oggi ha creato una cultura propria, messicana, molto forte come sappiamo, nella pittura, nella musica, nel cinema e in ogni campo. Il problema che abbiamo sempre è quello del dramma di milioni di poveri. Metà della popolazione continua a vivere in miseria. Questo è il grosso problema del Messico. Ecco che cosa non è cambiato; sono migliorate ventimila cose, ma continuiamo ad avere – in gran misura a causa dell’esplosione demografica, se vuole, ma in enorme misura anche per la corruzione ufficiale – 40 o 50 milioni di persone che vivono in povertà. È una tragedia ed è la sfida che sta davanti al Messico: togliere questa gente dalla miseria.
A proposito dell’importanza della diversità, il conte Branley, in Le relazioni lontane, dice: “L’arte, soprattutto l’arte di narrare, è un tentativo disperato per ristabilire l’analogia senza sacrificare la differenziazione. Questo è quello che hanno fatto Cervantes e Balzac, Proust e Dostoevskij… Non c’è romanziere che sfugga a questa terribile esigenza”. Si tratta di un altro modo per affrontare il tema del rapporto conflittuale fra tradizione e innovazione?
In buona misura sì. Io sono convinto che non vi sia creazione nuova che non assimili o non si appoggi alla tradizione precedente. Non può esserci una rottura radicale. A volte le avanguardie hanno tentato una rottura radicale con il passato, ma le cose non stanno così: ci si rifà sempre in qualche modo alla tradizione. E allo stesso modo la tradizione non sopravvive senza nuove creazioni che la nutrano. Una tradizione senza novità è destinata a declinare, muore. Quindi si pone il problema dell’analogia e della differenza, bisogna rinnovare senza spezzare la capacità analogica, e non direi anagogica, secondo la terminologia di san Tommaso d’Aquino, ma semplicemente analogica, secondo la terminologia di Dante, che impiega molto questo termine, per poter trovare la similitudine fra le cose, e le similitudini fra le cose non si scoprono soltanto attraverso il simile, ma molto più opportunamente attraverso la metafora. Non esiste letteratura senza metafore, ma se lo inscriviamo entro il problema del rapporto fra tradizione e innovazione, benissimo, questo per me semplifica e chiarisce il tema.
Sembra che con Gli anni con Laura Díaz lei abbia scritto la sua madame Bovary…
[Ride] Una madame Bovary di un secolo, no? Ha una durata temporale molto più lunga di quella del personaggio di Flaubert…
Laura sceglie la professione di fotografa, ma lei stessa in un certo senso assomiglia a una pellicola su cui vanno a fissasi tutti gli avvenimenti storici della sua vita, o a un personaggio di un murale di Diego Rivera. Dov’è che s’incontrano il piano storico e quello individuale del destino della sua Laura e di molti dei suoi personaggi?
Be’, io credo che risulti molto chiaro che Laura ha una forte personalità. È una ragazza che nasce nella regione da cui provenivano i miei nonni, nello stato di Veracruz, e mentre si svolge la sua esistenza scopre che non vive più nel mondo bucolico del lago di Catemajo, nello stato di Veracruz dov’era nata, bensì in un mondo pieno di conflitti che è quello del XX secolo. Il romanzo racconta la storia di Laura Díaz come persona e insieme la storia dei miei ricordi di cittadino che ha vissuto il XX secolo. Curiosamente, senza che ci fossimo messi d’accordo, la pubblicazione del romanzo ha coinciso con quella di Il mio secolo di Gunther Grass, che pure è una memoria del secolo, come Laura Diaz. Nel caso di Laura Díaz gli avvenimenti del secolo – la Rivoluzione messicana, l’ascesa dei fascismi in Europa, la guerra mondiale, il maccartismo, Xatelolco, in Messico, dove muore il nipote di Laura – e allo stesso tempo è lo sviluppo della biografia di una donna che a poco a poco trova se stessa, la sua vocazione e il suo destino nell’arte della fotografia.
Juan Francisco, il marito di Laura, a un certo punto dice fra sé: “Non sono molto diverso dagli altri. Tutti lottiamo per la rivoluzione e contro l’ingiustizia, ma anche contro il destino”. In questo assomiglia un po’ ad Artemio Cruz.
Sì, salvo che Artemio Cruz è molto furbo e sa approfittare della situazione, mentre Juan Francisco è un uomo estremamente debole, privo di volontà, soltanto una vittima delle circostanze, della cultura della corruzione nata in grande misura dalla Rivoluzione messicana, nel senso che, avendo effettivamente “rivoltato” la società, ha creato possibilità di ascesa per una borghesia che era molto arretrata a causa della dittatura di Porfirio Díaz. Si sono uniti alla rivoluzione e si sono arricchiti. Come diceva il generale Álvaro Obregón, non c’è militare messicano capace di resistere a una cannonata da 50.000 pesos. Nessuno ne è stato capace, è la verità.
La morte di Artemio Cruz è uno dei romanzi del “boom” della letteratura latinoamericana di fine anni ’60, e lei allora ha avuto un ruolo importante nel favorire il successo internazionale di alcuni scrittori. Poi è venuto quello che lei ha chiamato il “boomerang” –Isabel Allende, Marcela Serrano, Angeles Mastretta, ecc. –, che è stato un fenomeno soprattutto femminile, e ora in Messico c’è la “generazione del crack”, in Cile Alberto Fuguet con le antologie di McOndo e Se habla español. Qual è la sua opinione su questi ultimi movimenti?
Penso che siano movimenti molto fecondi di rottura e allo stesso tempo di assimilazione della tradizione. Rappresentano i giovani d’oggi, che è quello che siamo stati noi da giovani. Come potrei non simpatizzare con questi giovani, per esempio nel mio paese con Volpi, Padilla, Palou, e con una rivelazione, una scrittrice di trentaquattro anni, Cristina Rivera Garza, autrice di un romanzo prodigioso, Nadie me verá llorar [Nessuno mi vedrà piangere, Voland 2008; ndr], incentrato sui ricordi di un fotografo che conosce una donna in due posti: da giovane in un postribolo e da vecchia in un manicomio. È un romanzo veramente splendido, e spero sarà tradotto anche in Italia. Voglio dire comunque che si tratta di un periodo di grande vitalità per la letteratura latinoamericana. Per esempio in Argentina, con tutti i problemi che affliggono questo paese, c’è César Aira, che è uno straordinario innovatore, uno scrittore molto interessante, c’è Silvia Iparaguirre con un magnifico romanzo, La tierra del fuego, ci sono Piglia, Fresán, diversi scrittori di prim’ordine. È una situazione paradossale, perché l’Argentina ha forse i migliori scrittori di tutta l’America latina e la peggior politica dell’America latina… un divorzio totale.
In Geografia del romanzo lei dedica un saggio a Italo Calvino. C’è qualche altro scrittore italiano del secolo scorso che ha attirato il suo interesse?
In Messico e in America latina siamo cresciuti con i romanzieri italiani del secondo dopoguerra. Io ho una particolare simpatia e ammirazione per Calvino, ma potrei menzionare la straordinaria influenza, la lettura appassionata che si faceva in Messico e in America latina di Elio Vittorini, Cesare Pavese, Alberto Moravia…
Venivano tradotti?
Sì, altroché, erano tutti tradotti in Argentina. Elsa Morante, l’autore del Deserto dei tartari… Dino Buzzati, l’autore del Bell’Antonio, bene, voglio dire che c’è stata un’influenza enorme dei romazieri italiani, e un’influenza più ridotta ma molto profonda sulla poesia latinoamericana di Montale, naturalmente. Dimenticavo Gadda, che pure ha avuto una grossa influenza, e io credo che dagli anni ’50 agli ’80 c’è stata una presenza decisiva della letteratura italiana su quella latinoamericana, molto forte, davvero.
(Pubblicato su Pulp, estate 2002.)