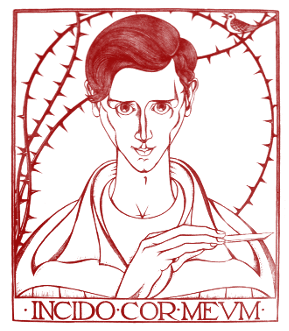Se amate la grande narrativa latinoamericana ma vi hanno via via deluso e poi decisamente annoiato gli esausti epigoni del realismo magico, I detectives selvaggi di Roberto Bolaño (Sellerio, traduzione di Maria Nicola) potrebbe propiziare una riconciliazione, l’occasione è ghiotta. Grazie alla pubblicazione, sempre per Sellerio, di La letteratura nazista in America, Stella distante, e di Amuleto per Mondadori (una nuova edizione è stata pubblicata da Adelphi nella traduzione di Ilide Carmignani), Bolaño non è certo uno sconosciuto da noi.
Adesso, con questo romanzo di oltre 800 pagine, arriva la sua opera a tutt’oggi più impegnativa (anche se lui, incurante delle lamentele degli editori, minaccia di superare le 1000 con quella in progress, di cui si conosce solo il titolo provvisorio: 2666). Sono parecchi i pregi de I detectives selvaggi, che giustificano le lodi convinte e pressoché unanimi della critica ispanofona dalle due parti dell’Oceano e gli importanti premi ricevuti: sul piano linguistico, per l’amplissimo registro geografico-sociale delle voci narranti; sul piano narrativo, per la sfida costituita da una struttura aperta e dal ricorso a generi perlopiù sottovalutati come il diario e il poliziesco, sul piano tematico per la testimonianza degli slanci e delle frustrazioni che hanno segnato un’epoca e la generazione che, vivendola, cercò di interpretarla.
Di che parla il romanzo?
La prima parte, intitolata “Messicani perduti in Messico (1975)”, è il diario di un paio di mesi del poeta diciassettenne Juan García Madero, a partire dalla sua cooptazione nel movimento realvisceralista.
La seconda, “I detectives selvaggi (1976-1986)”, la più estesa, raccoglie le testimonianze di vari personaggi, alcuni dei quali già incontrati nel diario, che ruotano intorno alla coppia di amici Arturo Belano e Ulíses Lima, leader indiscussi del “realvisceralismo”, e alla loro fissazione per Cesárea Tinajero, una misteriosa poetessa messicana d’avanguardia attiva negli anni ’20.
Nella terza parte, infine, viene ripreso il diario di García Madero, che racconta un viaggio on the road verso Sonora insieme a Belano, Lima e Lupe (una giovane prostituta di Città del Messico che cerca di sfuggire al suo magnaccia), il ritrovamento della poetessa e l’imprevedibile finale.
Se dapprima sembra configurarsi come un romanzo d’iniziazione con qualche tratto picaresco (le forsennate perfomance sessuali di García Madero, accompagnate da altrettanto forsennate letture), l’irruzione di numerosi personaggi che prendono la parola come se si trovassero di fronte a un microfono o a una telecamera, il dialogo serrato con la tradizione letteraria latinoamericana – incluse simpatie e antipatie dell’autore –, l’uso sapiente della suspence la rendono un’opera singolare, non ascrivibile a modelli o canoni preesistenti. Contiene episodi esilaranti, esercizi di stile, veri e propri divertissement, ma è un libro intriso di malinconia, perché racconta la storia di una fuga e di una sconfitta. Manda in fibrillazione il lettore erudito ed esigente, ma è una festa anche per quello che ama trame e azione. È popolato di personaggi sfuggenti, come Belano e Lima, che ci vengono presentati sempre in maniera obliqua, come appaiono nei ricordi di amici e conoscenti – poeti? rivoluzionari? ma se erano soltanto degli spacciatori di marihuana! –, e di altre figure che si conquistano una dimensione di rilievo, come la bella e sensuale María Font o suo padre, l’inquieto architetto Quim, avviato sulla china del manicomio. Narra un’epopea senza ostentare toni epici, con accenni di lirismo estremamente contenuti, e… mette una gran voglia di diventare “poeti realvisceralisti” e di partire per qualche deserto.
(Pubblicato su Pulp, giugno 2003 e poi nell’Archivio Bolaño)